Affari militari tra i romani Conquiste romane Dovere militare Dovere militare e dovere civico La legione romana e le sue unità Armamento del legionario Armamento del legionario e tattica di battaglia tattica di battaglia Legione in campagna Legione in campagna e nell'accampamento Assedio delle città Flotta: come i popoli della “terra” divennero padroni del Mar Mediterraneo Guerra e diplomazia Fonti del dizionarioFonti su Internet


Conquiste romane - II TEMPO con cui combatterono i romani Ciò che fu aggiunto dopo i secoli VI-IV. AVANTI CRISTO. Etruschi, tribù italiche (Sanniti, Latini, ecc.), Greci dalle colonie in Italia Penisola Appenninica (Italia) Roma si unisce alla lotta per il dominio nel Mediterraneo nel III-II secolo. AVANTI CRISTO. Cartagine, Macedonia, Grecia, Siria, Africa settentrionale, Spagna, Grecia, Macedonia, Asia Minore, Gallia meridionale Roma divenne nel I secolo la più grande potenza del Mediterraneo. AVANTI CRISTO. Celti della Gallia, regni del Ponto e dell'Egitto, Germani della Gallia, Egitto, Siria, Tracia, rive del Reno L'influenza di Roma si diffuse in tutte le regioni sviluppate dell'Europa e del Medio Oriente nel I-II secolo. ANNO DOMINI Parti, Daci, Celti della Britannia, Germani e altri “barbari” delle terre a sud del Danubio, Giudea, Dacia, Britannia, Armenia Roma si mosse per difendere i suoi confini lungo il Reno, il Danubio e l'Eufrate. L'Impero ha mangiato troppo

Chi prestò servizio nell'esercito romano? Già nel VI secolo. AVANTI CRISTO. Il re Servio Tullio divise i cittadini di Roma in categorie patrimoniali, ciascuna delle quali doveva schierare un determinato numero di soldati. Un guerriero acquistò armi a proprie spese Alla fine del II secolo. AVANTI CRISTO. molti romani non potevano più acquistare armi da soli. Quindi il comandante Gaius Mari propose di reclutare un esercito di mercenari, guerrieri professionisti che potrebbero non avere alcuna proprietà




Legione in battaglia Durante il periodo repubblicano la legione da battaglia era costituita da tre linee lungo i manipoli. Ogni manipolo era costruito a forma di quadrato, con intervalli uguali tra i suoi vicini lungo la linea. Prima della formazione della legione c'erano arcieri, frombolieri e lanciatori di giavellotto. Gli hastati erano nella prima linea dello schieramento, i principi nella seconda, e i triarii nella terza. La cavalleria era posizionata sui fianchi. La legione si avvicinò rapidamente al nemico, inondandolo di lance. L'esito della battaglia veniva solitamente deciso dal combattimento corpo a corpo. AVANTI CRISTO. la legione cominciò a essere organizzata in coorti più grandi, formando tre linee secondo uno schema a scacchiera.

Assalto e assedio alle fortezze Presero la fortezza: con un attacco improvviso fin dalla strada, tentarono di sfondare le porte sotto la copertura degli scudi. Attacco (assalto) Balista legionaria Torre d'assedio Se un attacco era impossibile, iniziavano l'assedio di un punto fortificato: circondandolo su tutti i lati con le truppe. Se questo luogo era troppo fortificato e abbondantemente rifornito di provviste, lo prendevano d'assalto con l'aiuto di installazioni d'assedio e macchine da guerra. Ram

Un esercito in campagna Di solito, durante una campagna, l'esercito era in viaggio per 7 ore al giorno, percorrendo fino a 30 km. I soldati furono costretti a portare con sé tutte le loro proprietà e le armi. Gli esploratori camminavano avanti, obbligati a esaminare l'area, raccogliere informazioni sul nemico e scegliere un luogo per l'accampamento. Poi venne l'avanguardia, composta da cavalleria e fanteria leggera; Dietro di lui si mossero le forze principali dell'esercito. Marciavano in una colonna, ogni legione era seguita dal suo convoglio di bagagli e truppe armate alla leggera formavano la retroguardia. Se il nemico era vicino, il grosso dell'esercito si muoveva in formazione di battaglia, seguito dall'intero convoglio e parte dell'esercito fungeva da copertura (retroguardia). Durante la ritirata, il convoglio fu inviato avanti con un distaccamento di truppe, e il resto li seguì.



Glossario La legione è una grande unità dell'esercito romano (da 4,5 a 7mila persone). Legionario: guerriero della legione. Struttura, vedi Struttura, vedi Centuria - un distaccamento di cento (dal I secolo a.C. - 80) legionari Centurione - un giovane ufficiale dell'esercito romano, comandante di una centuria o manipolo Manipula - un distaccamento che comprende 2-3 secoli. Fino al I secolo. AVANTI CRISTO. L'esercito romano era costruito su 3 file lungo i manipoli. 3 file lungo i manipoli - dal I secolo. AVANTI CRISTO. la divisione principale di una legione di 6 (meno spesso 10) secoli. La coorte era comandata dal tribuno militare Ballista, un'arma da lancio a forma di un grande arco orizzontale, rinforzato con un paio di corde ritorte verticali. Ha lanciato frecce, pietre, sfere di metallo. Utilizzato sulle navi e durante l'assedio delle fortezze.

Glossario (continua) Gli Hastati (lancieri) sono giovani guerrieri che combattevano in prima linea nella legione. Iniziarono la battaglia lanciando lance contro il nemico da una lunga distanza, e poi attaccarono con le spade in mano. I Principes sono guerrieri esperti della seconda linea della formazione della legione. Sono entrati nella battaglia nel momento più decisivo, decidendone l'esito. Triarii - guerrieri della terza linea della formazione delle legioni, veterani. Sono entrati in battaglia solo nei casi più estremi. Concubernius è un gruppo di guerrieri (8-10 persone) che vivono in una tenda e cucinano insieme il cibo mentre riposano nell'accampamento. Era diretto da un caposquadra (decurione). Legato: assistente console, comandante della legione.

Fonti e letteratura Materiali utilizzati da Internet: – – – – –Listvin G. Quaderno di esercizi sulla storia dell'antica Roma (i materiali sono in preparazione per la pubblicazione) Letteratura consigliata: –Marx E., Tinjey G. Romans. M., Rosmann, 1994; -Plutarco Biografie comparate. M., Scienza, volumi; -Vegezio. Breve riassunto degli affari militari // Lettore sulla storia dell'antica Roma. M., Scuola superiore, 1987
"Stato romano antico" - Stato romano. Gli obiettivi perseguiti dagli avversari nella guerra. Antico stato romano. Definizioni dei termini. Vicinato. Spiega il significato dell’espressione “guai ai vinti”. Popolazione dell'Italia. Senato. Console. Tenute di Roma. Lo stato romano divenne una repubblica. Eventi militari. Giustificare il potere. Inventa una frase.
“Periodi della storia dell'antica Roma” - Politica estera. Popoli abitatori. Servio Tullio. Stratificazione. Struttura politica. Guerra di Macedonia. Fondazione di Roma. L'inizio di Roma. Seconda guerra latina. La caduta del potere reale. III Guerra Punica. Annibale Barca. Campidoglio. Tarquinio l'Antico. Romolo. Storia di Roma. I Guerra Punica.
"L'inizio della storia romana" - I romani erano impegnati nell'agricoltura. Tribuna Popolare. L'originalità degli Etruschi. Etruschi. occupazioni romane. La leggenda della fondazione di Roma. Residenti a Roma. Senato. Tribune Popolari. La data di fondazione di Roma è il 753 a.C. Il sistema di gestione nell'antica Roma. L'inizio della storia romana. Paese e popolazione. Fondazione di Roma.
“Roma Antica” 10a elementare - Gli scultori abbandonarono le composizioni frontali. Ascesa di Spartaco. Declino e morte dell'Impero Romano. L'esercito romano sotto Ottaviano Augusto e i suoi successori. Leggenda sulla fondazione di Roma. Schiavitù a Roma. Cultura dell'Impero Romano. La sconfitta del regno siriano. Antica Roma. Mulini ad acqua. L'ascesa della letteratura.
“Storia del mondo “Antica Roma”” - Posizione geografica e condizioni naturali e climatiche. Data leggendaria della fondazione di Roma. I romani erano impegnati nell'agricoltura. Roma è una città sui sette colli. Marte. Gli antichi romani vivevano in case primitive fatte di ramoscelli di salice. I patrizi sono i discendenti degli abitanti originari di Roma. Residenti a Roma. Leggi attentamente il testo della leggenda.
"Roma" - 2 consoli. Nelle vicinanze c'erano un giardino e un orto, e fuori città c'erano campi e pascoli. Gli abitanti di Roma erano abili artigiani: fabbri, tessitori, ceramisti. Come risultato delle continue guerre con le città vicine, i romani ampliarono il loro territorio. Roma vista dall'alto. Molti dei mulini più antichi sono ancora funzionanti.
Ci sono un totale di 13 presentazioni nell'argomento
Anteprima:
Per utilizzare le anteprime delle presentazioni, crea un account Google e accedi ad esso: https://accounts.google.com
Didascalie delle diapositive:
Seconda guerra tra Roma e Cartagine
Piano: 1. Le truppe di Annibale invadono l'Italia. 2. Battaglia di Cannes. 3. Fine della guerra. Concetti chiave: Sicilia, Cartagine, Annibale, Cannes, Scipione, Zama
Guarda la mappa. - Quali paesi erano i leader nel Mediterraneo? - Quali territori appartenevano a queste potenze? - Quali ragioni provocarono le guerre tra Roma e Cartagine?
Trova l'isola della Sicilia sulla mappa - Dove si trova Cartagine - Trova i confini della Repubblica Romana?
Guerre puniche Prima guerra punica (264-241 a.C.) Seconda guerra punica (218-201 a.C.) Terza guerra punica (149-146 a.C.)
Scrivi il motivo della guerra tra Roma e Cartagine: La guerra per il possesso di nuovi territori sulla costa del Mediterraneo occidentale.
Cartagine perse la prima guerra punica. -La Sicilia è andata a Roma. -Entrambe le parti iniziarono a prepararsi per una nuova guerra. Confronta gli eserciti dei partecipanti alla guerra. domande Esercito di Roma Esercito di Cartagine Composizione Punti di forza Punti di debolezza
1.Le truppe di Annibale invadono l'Italia. Annibale decise di superare i suoi rivali e colpire per primo. Per fare questo, guidò personalmente l'esercito e lasciò la Spagna nel 218. AVANTI CRISTO. Dopo 5 mesi si avvicina alle Alpi.
Segui il percorso delle truppe di Annibale sulla mappa
ANNIBALE attraversa il Rodano.
Annibale diede l'ordine di attraversare le montagne innevate. Per 15 giorni l'esercito salì e poi scese. Annibale perse metà del suo esercito.
Le tribù della Gallia aiutarono Annibale e si unirono ai suoi ranghi
La prima battaglia seria ebbe luogo a Canne nel 216 a.C. Lavoro indipendente. Considera lo schema di battaglia. - Perché l'esercito di Annibale (40mila persone) riuscì a sconfiggere l'esercito romano (80mila persone)
Annibale schierò 40mila fanti: a mezzaluna, con il lato convesso rivolto verso il nemico.
Perché pensi che i romani furono sconfitti? Non c'era unità nel comando, Annibale pensò attentamente alle tattiche.
3. Fine della guerra. Lavoro indipendente: scrivi le ragioni della sconfitta dell'esercito di Annibale Le ragioni della sconfitta di Annibale: - la popolazione locale, ad eccezione dei Galli, non sostenne Annibale - l'alleanza romano-italiana resistette La posizione di Annibale peggiorò. I governanti di Cartagine non avevano fretta di aiutare, perché avevano paura che Annibale prendesse il potere a Cartagine.
D.Z. §47, annotare date, nomi
Questo numero è realizzato sulla base della "Storia militare" in tre volumi di Razin e del libro "On Seven Hills" di M.Yu German, B.P Seletsky, Yu.P. La questione non è uno studio storico speciale ed è destinata ad aiutare coloro che sono impegnati nella produzione di miniature militari.
Breve cenni storici
L'antica Roma è uno stato che conquistò i popoli dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e della Gran Bretagna. I soldati romani erano famosi in tutto il mondo per la loro ferrea disciplina (ma non sempre era di ferro) e per le brillanti vittorie. I comandanti romani passarono di vittoria in vittoria (ci furono anche gravi sconfitte), finché tutti i popoli del Mediterraneo si ritrovarono sotto il peso dello stivale del soldato.
L'esercito romano in tempi diversi aveva numeri diversi, numero di legioni e formazioni diverse. Con il miglioramento dell'arte militare, le armi, le tattiche e la strategia cambiarono.
A Roma vigeva la coscrizione universale. I giovani iniziarono a prestare servizio nell'esercito dall'età di 17 anni fino a 45 in unità di campo, dopo i 45-60 prestarono servizio nelle fortezze. Le persone che hanno partecipato a 20 campagne di fanteria e 10 di cavalleria erano esentate dal servizio. Anche la durata è cambiata nel tempo.
Un tempo, poiché tutti volevano prestare servizio nella fanteria leggera (le armi costavano poco e venivano acquistate a proprie spese), i cittadini di Roma erano divisi in categorie. Ciò è stato fatto sotto Servio Tullio. La prima categoria comprendeva coloro che possedevano beni di valore non inferiore a 100.000 assi di rame, la 2a almeno 75.000 assi, la 3a - 50.000 assi, la 4a - 25.000 assi, la 5a -mu - 11.500 assi. Tutti i poveri erano inclusi nella sesta categoria: i proletari, la cui ricchezza era solo la loro prole ( prolet). Ogni categoria di proprietà schierava un certo numero di unità militari - centurie (centinaia): 1a categoria - 80 centurie di fanteria pesante, che costituivano la principale forza combattente, e 18 centurie di cavalieri; solo 98 secoli; 2° – 22; 3° – 20; 4° – 22; 5° - 30 secoli con armamento leggero e 6° categoria - 1 secolo, per un totale di 193 secoli. I guerrieri leggermente armati venivano usati come servitori dei bagagli. Grazie alla divisione in ranghi, non mancavano fanteria e cavalieri armati pesantemente e leggermente armati. I proletari e gli schiavi non prestavano servizio perché non godevano di fiducia.
Nel corso del tempo, lo stato si è assunto non solo il mantenimento del guerriero, ma gli ha anche trattenuto il salario per cibo, armi e attrezzature.
Dopo una dura sconfitta a Cannes e in molti altri luoghi, dopo le guerre puniche, l'esercito fu riorganizzato. Gli stipendi furono notevolmente aumentati e ai proletari fu permesso di prestare servizio nell'esercito.
Le guerre continue richiedevano molti soldati, cambiamenti nelle armi, nella costruzione e nell'addestramento. L'esercito divenne mercenario. Un simile esercito potrebbe essere condotto ovunque e contro chiunque. Questo è ciò che accadde quando salì al potere Lucio Cornellio Silla (I secolo a.C.).
Organizzazione dell'esercito romano
Dopo le guerre vittoriose dei secoli IV-III. AVANTI CRISTO. Tutti i popoli d'Italia passarono sotto il dominio di Roma. Per mantenerli nell'obbedienza, i romani diedero ad alcuni popoli più diritti, ad altri meno, seminando tra loro diffidenza e odio reciproci. Furono i romani a formulare la legge del “divide et impera”.
E per questo erano necessarie numerose truppe. Pertanto, l'esercito romano era composto da:
a) legioni in cui prestavano servizio gli stessi romani, costituite da fanteria pesante e leggera e cavalleria loro assegnata;
b) alleati italiani e cavalleria alleata (dopo aver concesso i diritti di cittadinanza agli italiani che si unirono alla legione);
c) truppe ausiliarie reclutate tra gli abitanti delle province.
La principale unità tattica era la legione. Al tempo di Servio Tullio, la legione contava 4.200 uomini e 900 cavalieri, senza contare 1.200 soldati armati alla leggera che non facevano parte dei ranghi di combattimento della legione.
Il console Marco Claudio cambiò la struttura della legione e delle armi. Ciò accadde nel IV secolo a.C.
La legione era divisa in manipoli (dal latino una manciata), secoli (centinaia) e decurii (decine), che assomigliavano a compagnie, plotoni e squadre moderne.
La fanteria leggera - i veliti (letteralmente - veloci, mobili) camminavano davanti alla legione in una formazione libera e iniziarono una battaglia. In caso di fallimento, si ritirava nella parte posteriore e sui fianchi della legione. C'erano 1200 persone in totale.
Hastati (dal latino "gast" - lancia) - lancieri, 120 persone in un manipolo. Formavano la prima linea della legione. Principi (primo) – 120 persone nella manipola. Seconda linea. Triarii (terzo) – 60 persone in un manipolo. Terza riga. I triarii erano i combattenti più esperti e collaudati. Quando gli antichi vollero dire che era arrivato il momento decisivo, dissero: “È giunto ai triarii”.
Ogni manipolo aveva due secoli. Nel secolo degli hastati o principi c'erano 60 persone, e nel secolo dei triarii c'erano 30 persone.
Alla legione furono assegnati 300 cavalieri, per un totale di 10 turmas. La cavalleria copriva i fianchi della legione.
All'inizio dell'uso dell'ordine manipolare, la legione entrava in battaglia su tre linee, e se si incontrava un ostacolo che costringeva i legionari a spostarsi, ciò si traduceva in una lacuna nella linea di battaglia, il manipolo dal la seconda linea si affrettò a colmare il divario, e il manipolo della seconda linea prese il posto del manipolo della terza linea. Durante la battaglia con il nemico, la legione rappresentava una falange monolitica.
Col tempo la terza linea della legione cominciò ad essere utilizzata come riserva che decise le sorti della battaglia. Ma se il comandante avesse determinato erroneamente il momento decisivo della battaglia, la legione avrebbe dovuto affrontare la morte. Pertanto, nel tempo, i romani passarono alla formazione di coorte della legione. Ciascuna coorte contava 500-600 persone e, con un distaccamento di cavalleria annesso, che operava separatamente, era una legione in miniatura.
Struttura di comando dell'esercito romano
In epoca zarista, il comandante era il re. Durante la Repubblica i consoli comandavano dividendo le truppe a metà, ma quando era necessario unire comandavano alternativamente. Se c'era una minaccia seria, veniva scelto un dittatore, al quale era subordinato il capo della cavalleria, in contrapposizione ai consoli. Il dittatore aveva diritti illimitati. Ogni comandante aveva assistenti a cui erano affidate singole parti dell'esercito.
Le singole legioni erano comandate da tribuni. Ce n'erano sei per legione. Ciascuna coppia comandò per due mesi, sostituendosi ogni giorno, poi cedendo il posto alla seconda coppia, ecc. I centurioni erano subordinati ai tribuni. Ogni centuria era comandata da un centurione. Il comandante dei primi cento era il comandante del manipolo. I centurioni avevano il diritto di un soldato per cattiva condotta. Portavano con sé una vite: una verga romana, quest'arma raramente veniva lasciata inattiva. Lo scrittore romano Tacito parlò di un centurione, che l'intero esercito conosceva con il soprannome: "Passa oltre!" Dopo la riforma di Mario, collaboratore di Silla, i centurioni dei triarii acquisirono grande influenza. Sono stati invitati a un consiglio militare.
Come ai nostri tempi, l'esercito romano aveva stendardi, tamburi, timpani, trombe e corni. Gli stendardi erano una lancia con una traversa, sulla quale era appeso un pannello di materiale monocolore. I manipoli, e dopo la riforma di Maria le coorti, avevano stendardi. Sopra la traversa c'era l'immagine di un animale (lupo, elefante, cavallo, cinghiale...). Se un'unità compiva un'impresa, veniva premiata: il premio era attaccato all'asta della bandiera; questa usanza è sopravvissuta fino ad oggi.
Lo stemma della legione sotto Maria era un'aquila d'argento o di bronzo. Sotto gli imperatori era d'oro. La perdita dello stendardo era considerata la vergogna più grande. Ogni legionario doveva difendere lo stendardo fino all'ultima goccia di sangue. Nei momenti difficili, il comandante lanciava lo stendardo in mezzo ai nemici per incoraggiare i soldati a restituirlo e disperdere i nemici.
La prima cosa che veniva insegnata ai soldati era di seguire incessantemente il distintivo, lo stendardo. Gli alfieri erano scelti tra soldati forti ed esperti ed erano tenuti in grande stima e rispetto.
Secondo la descrizione di Tito Livio, gli stendardi erano un pannello quadrato allacciato ad una traversa orizzontale montata su un palo. Il colore del tessuto era diverso. Erano tutti monocromatici: viola, rosso, bianco, blu.
Fino alla fusione della fanteria alleata con quella romana, era comandata da tre prefetti scelti tra i cittadini romani.
Grande importanza veniva attribuita al servizio del quartiermastro. Il capo del servizio quartiermastro era il questore, incaricato del foraggio e dei viveri per l'esercito. Si è assicurato che tutto il necessario fosse consegnato. Inoltre, ogni secolo aveva i suoi raccoglitori. Un ufficiale speciale, come un capitano di un esercito moderno, distribuiva il cibo ai soldati. Nel quartier generale c'era uno staff di scribi, contabili, cassieri che distribuivano stipendi a soldati, preti-indovini, ufficiali della polizia militare, spie e trombettisti.
Tutti i segnali venivano inviati attraverso un tubo. Il suono della tromba è stato provato con corni ricurvi. Quando si cambiava la guardia, veniva suonata una tromba di futsin. La cavalleria utilizzava uno speciale tubo lungo, ricurvo all'estremità. Il segnale di radunare le truppe per l'assemblea generale fu dato da tutti i trombettieri riuniti davanti alla tenda del comandante.
Addestramento nell'esercito romano
L'addestramento dei soldati della legione manipolare romana consisteva principalmente nell'insegnare ai soldati ad avanzare agli ordini del centurione, a colmare le lacune nella linea di battaglia al momento dello scontro con il nemico e ad affrettarsi a fondersi con il generale. massa. L'esecuzione di queste manovre richiedeva un addestramento più complesso di quello di un guerriero che combatteva in falange.
L'addestramento consisteva anche nel fatto che il soldato romano era sicuro che non sarebbe stato lasciato solo sul campo di battaglia, che i suoi compagni si sarebbero precipitati in suo aiuto.
La comparsa di legioni divise in coorti, la complicazione delle manovre, richiedevano un addestramento più complesso. Non è un caso che dopo la riforma di Mario, uno dei suoi collaboratori, Rutilio Rufo, introdusse un nuovo sistema di addestramento nell'esercito romano, che ricordava il sistema di addestramento dei gladiatori nelle scuole dei gladiatori. Solo i soldati ben addestrati (addestrati) potevano superare la paura e avvicinarsi al nemico, attaccare un'enorme massa nemica da dietro, sentendo solo una coorte nelle vicinanze. Solo un soldato disciplinato potrebbe combattere in questo modo. Sotto Maria fu introdotta una coorte, che comprendeva tre manipoli. La legione aveva dieci coorti, senza contare la fanteria leggera, e da 300 a 900 cavalieri.
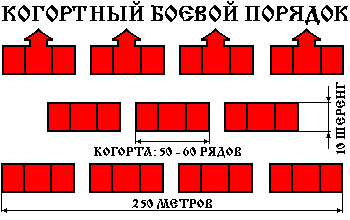 |
|
Fig. 3 – Formazione della battaglia di coorte. |
Disciplina
L'esercito romano, famoso per la sua disciplina, a differenza degli altri eserciti dell'epoca, era interamente alla mercé del comandante.
La minima violazione della disciplina era punibile con la morte, così come il mancato rispetto degli ordini. Quindi, nel 340 a.C. il figlio del console romano Tito Manlio Torquato, durante la ricognizione senza ordini del comandante in capo, entrò in battaglia con il capo del distaccamento nemico e lo sconfisse. Ne parlò con gioia al campo. Tuttavia, il console lo condannò a morte. La sentenza è stata eseguita immediatamente, nonostante le richieste di pietà di tutto l'esercito.
Davanti al console camminavano sempre dieci littori, portando fasci di verghe (fasciae, fascines). In tempo di guerra, vi veniva inserita un'ascia. Un simbolo del potere del console sui suoi uomini. Per prima cosa, l'autore del reato è stato frustato con delle verghe, poi la sua testa è stata tagliata con un'ascia. Se parte o tutto l'esercito mostrava codardia in battaglia, veniva effettuata la decimazione. Decem in russo significa dieci. Questo è ciò che fece Crasso dopo la sconfitta di diverse legioni da parte di Spartaco. Diverse centinaia di soldati furono fustigati e poi giustiziati.
Se un soldato si addormentava al suo posto, veniva processato e poi picchiato a morte con pietre e bastoni. Per reati minori potevano essere fustigati, retrocessi, trasferiti a lavori forzati, ridotti di stipendio, privati della cittadinanza o venduti come schiavi.
Ma c'erano anche delle ricompense. Potevano promuoverli di grado, aumentare il loro stipendio, ricompensarli con terra o denaro, esentarli dal lavoro nei campi e premiarli con insegne: catene d'argento e d'oro, braccialetti. La cerimonia di premiazione è stata effettuata dallo stesso comandante.
I premi abituali erano medaglie (faleras) con l'immagine di un dio o di un comandante. Le insegne più alte erano ghirlande (corone). La quercia fu donata a un soldato che salvò un compagno, un cittadino romano, in battaglia. Una corona con una merlatura - a colui che per primo scalò il muro o il bastione di una fortezza nemica. Una corona con due archi d'oro di navi - al soldato che per primo salì sul ponte di una nave nemica. La corona d'assedio veniva consegnata al comandante che revocava l'assedio di una città o fortezza o la liberava. Ma la ricompensa più alta, il trionfo, fu data al comandante per una vittoria eccezionale, nella quale dovettero essere uccisi almeno 5.000 nemici.
Il trionfante cavalcava su un carro dorato indossando una veste viola ricamata con foglie di palma. Il carro era trainato da quattro cavalli bianchi come la neve. Davanti al carro trasportavano il bottino di guerra e conducevano i prigionieri. L'uomo trionfante fu seguito da parenti e amici, cantautori e soldati. Furono cantate canzoni trionfanti. Ogni tanto si sentivano grida di "Io!" e "Trionfo!" (“Io!” corrisponde al nostro “Evviva!”). Lo schiavo in piedi dietro il carro trionfante gli ricordò che era un semplice mortale e che non doveva diventare arrogante.
Ad esempio, i soldati di Giulio Cesare, innamorati di lui, lo seguivano, prendendolo in giro e ridendo della sua calvizie.
accampamento romano
L'accampamento romano era ben pensato e fortificato. L'esercito romano, come si diceva, portò con sé la fortezza. Non appena fu fatta una sosta, iniziò immediatamente la costruzione del campo. Se fosse stato necessario andare avanti, il campo sarebbe stato abbandonato incompiuto. Anche se fu sconfitto solo per un breve periodo, differiva da quello di un giorno con fortificazioni più potenti. A volte l'esercito rimaneva nell'accampamento per l'inverno. Questo tipo di campo era chiamato campo invernale invece di tende, venivano costruite case e baracche; A proposito, sul sito di alcuni accampamenti romani sorsero città come Lancaster, Rochester e altre. Colonia (colonia romana di Agripinna), Vienna (Vindobona) sorsero dagli accampamenti romani... Sul luogo degli accampamenti romani sorsero città che terminavano in “...chester” o “...castrum”. “Castrum” - accampamento.
Il campeggio è stato scelto sul pendio secco meridionale della collina. Nelle vicinanze avrebbero dovuto esserci acqua e pascoli per il bestiame da trasporto, oltre al carburante.
Il campo era un quadrato, poi un rettangolo, la cui lunghezza era un terzo maggiore della larghezza. Innanzitutto fu pianificata l'ubicazione del pretorio. Questa è un'area quadrata, il cui lato è di 50 metri. Qui furono collocate le tende del comandante, gli altari e una piattaforma per rivolgersi ai soldati del comandante; Qui si sono svolti il processo e il raduno delle truppe. A destra c'era la tenda del questore, a sinistra i legati. Su entrambi i lati c'erano tende delle tribune. Davanti alle tende una strada larga 25 metri attraversava tutto il campo; la strada principale era attraversata da un'altra larga 12 metri; Alle estremità delle strade c'erano porte e torri. C'erano baliste e catapulte su di loro (la stessa arma da lancio, prende il nome dal proiettile lanciato, balista, palle di cannone in metallo, catapulta - frecce). Sui lati si trovavano in file regolari le tende dei legionari. Dall'accampamento le truppe potevano intraprendere una campagna senza clamori e disordini. Ogni centuria occupava dieci tende e ogni manipolo ne occupava venti. Le tende avevano una struttura di assi, un tetto di assi a due falde ed erano coperte di pelle o di lino grezzo. Superficie tenda da 2,5 a 7 mq. m. Vi viveva una decuria: 6-10 persone, due delle quali erano costantemente di guardia. Le tende della guardia pretoriana e della cavalleria erano grandi. L'accampamento era circondato da una palizzata, da un fossato ampio e profondo e da un bastione alto 6 metri. Tra i bastioni e le tende dei legionari c'era una distanza di 50 metri. Ciò è stato fatto in modo che il nemico non potesse dare fuoco alle tende. Davanti al campo è stato allestito un percorso a ostacoli costituito da diverse linee compensative e barriere costituite da pali appuntiti, fosse del lupo, alberi con rami appuntiti e intrecciati, formando un ostacolo quasi invalicabile.
I leggings venivano indossati dai legionari romani fin dall'antichità. Furono aboliti sotto gli imperatori. Ma i centurioni continuarono a indossarli. I gambali avevano il colore del metallo di cui erano fatti e talvolta venivano dipinti.
Ai tempi di Maria i vessilli erano d'argento, ai tempi dell'impero erano d'oro. I pannelli erano multicolori: bianco, blu, rosso, viola.
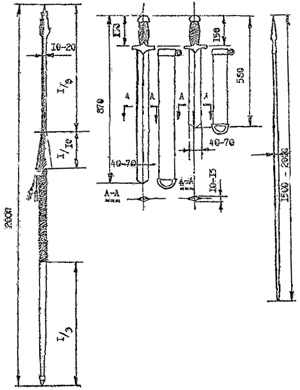 |
|
Riso. 7 – Armi. |
Una spada da cavalleria è una volta e mezza più lunga di una spada da fanteria. Le spade erano a doppio taglio, i manici erano fatti di osso, legno e metallo.
Un pilum è una lancia pesante con punta e asta in metallo. Punta seghettata. L'albero è in legno. La parte centrale della lancia è avvolta strettamente, girata per girare, con una corda. All'estremità del cordone venivano realizzate una o due nappe. La punta della lancia e l'asta erano di ferro dolce forgiato, prima che il ferro fosse di bronzo. Il pilum veniva lanciato contro gli scudi nemici. La lancia che affondò nello scudo lo tirò verso il basso e il guerriero fu costretto a lanciare lo scudo, poiché la lancia pesava 4-5 kg e si trascinava sul terreno, poiché la punta e l'asta erano piegate.
 |
|
Riso. 8 – Scutum (scudi). |
Gli scudi (scutums) acquisirono una forma semicilindrica dopo la guerra con i Galli nel IV secolo. AVANTI CRISTO e. Gli scudi erano realizzati con tavole di pioppo o pioppo leggere, ben essiccate e ben aderenti, ricoperte di lino e sopra con pelle di mucca. Il bordo dello scudo era delimitato da una striscia di metallo (bronzo o ferro) e le strisce erano disposte a croce al centro dello scudo. Al centro c'era una placca appuntita (umbon) - la parte superiore dello scudo. I legionari conservavano un rasoio, denaro e altre piccole cose (era rimovibile). All'interno era presente un passante per la cintura e una staffa metallica, su cui era scritto il nome del proprietario e il numero della centuria o coorte. La pelle poteva essere tinta: rossa o nera. La mano veniva inserita nel passante della cintura e afferrata dalla staffa, grazie alla quale lo scudo pendeva saldamente sulla mano.
L'elmo al centro è precedente, quello a sinistra è successivo. L'elmo aveva tre piume lunghe 400 mm; anticamente gli elmi erano di bronzo, poi di ferro. L'elmo era talvolta decorato con serpenti sui lati, che nella parte superiore formavano un luogo in cui venivano inserite le piume. In epoche successive l'unica decorazione sull'elmo era lo stemma. Sulla sommità della testa l'elmo romano aveva un anello nel quale era infilata una cinghia. L'elmo veniva indossato sulla schiena o sulla parte bassa della schiena, proprio come si indossa un elmo moderno.
I veliti romani erano armati di giavellotti e scudi. Gli scudi erano rotondi, di legno o di metallo. I veliti indossavano tuniche più tardi (dopo la guerra con i Galli) anche tutti i legionari iniziarono a indossare i pantaloni; Alcuni veliti erano armati di fionde. I frombolieri avevano sacchi per le pietre appesi sul lato destro, sopra la spalla sinistra. Alcuni veliti potrebbero aver avuto spade. Gli scudi (di legno) erano ricoperti di pelle. Il colore dell'abbigliamento può essere qualsiasi colore tranne il viola e le sue sfumature. I veliti potevano indossare sandali o camminare a piedi nudi. Gli arcieri apparvero nell'esercito romano dopo la sconfitta dei romani nella guerra con i Parti, dove morirono il console Crasso e suo figlio. Lo stesso Crasso che sconfisse le truppe di Spartaco a Brundisium.
|
Fig 12 – Centurione. |
I centurioni avevano elmi placcati in argento, non avevano scudi e portavano la spada sul lato destro. Avevano gli schinieri e, come segno distintivo sull'armatura, sul petto avevano l'immagine di una vite arrotolata ad anello. Durante i tempi della formazione manipolare e di coorte delle legioni, i centurioni erano sul fianco destro delle centurie, dei manipoli, delle coorti. Il mantello è rosso e tutti i legionari indossavano mantelli rossi. Solo il dittatore e i comandanti anziani avevano il diritto di indossare mantelli viola.
Le pelli di animali servivano da selle. I romani non conoscevano le staffe. Le prime staffe erano anelli di corda. I cavalli non erano ferrati. Pertanto, i cavalli erano molto curati.
Riferimenti
1. Storia militare. Razin, 1-2 t., Mosca, 1987
2. Sui sette colli (Saggi sulla cultura dell'antica Roma). M.Yu. Tedesco, B.P. Seletsky, Yu.P. Suzdal; Leningrado, 1960.
3. Annibale. Tito Livio; Mosca, 1947.
4. Spartaco. Raffaello Giovagnoli; Mosca, 1985.
5. Bandiere del mondo. K.I. Ivanov; Mosca, 1985.
6. Storia dell'antica Roma, sotto la direzione generale di V.I. Kuzishchina; Mosca, 1981.
Pubblicazione:
Biblioteca della Commissione Storica Militare - 44, 1989
L'antica Roma era uno dei più grandi imperi. Un impero che conquistò gran parte del mondo allora conosciuto. Questo stato ha avuto un'enorme influenza sull'intero ulteriore processo di sviluppo della civiltà e il perfezionamento di alcune strutture e organizzazioni di questo paese non è stato ancora superato.
Possiamo tranquillamente affermare che dal momento della sua nascita le parole Impero Romano e i concetti di “ordine”, “organizzazione” e “disciplina” divennero sinonimi. Ciò vale in pieno per l'antico esercito romano, i legionari, che ispiravano stupore e rispetto tra i popoli barbari...
Un combattente completamente equipaggiato ed equipaggiato era armato con una spada (in latino "gladius"), diversi dardi ("plumbatae") o lance ("pila"). Per proteggersi, i legionari utilizzavano un grande scudo rettangolare (“scutum”). Le tattiche di battaglia dell'antico esercito romano erano piuttosto semplici: prima dell'inizio della battaglia, il nemico veniva colpito con lance e dardi, dopo di che iniziava il combattimento corpo a corpo. Ed era in questi combattimenti corpo a corpo, in cui i romani preferivano combattere in una formazione molto densa, composta da più file, dove le file posteriori premevano contro quelle anteriori, sostenendo e spingendo contemporaneamente in avanti, che i vantaggi di fu rivelata la spada dei legionari, cioè gladio
Gladio e spatha
Il fatto è che il gladio era un'arma quasi ideale per lavorare in formazione serrata: la lunghezza totale dell'arma (non superiore a 60 centimetri) non richiedeva spazio per oscillare, e l'affilatura della lama stessa consentiva di sferrare entrambi colpi taglienti e perforanti (anche se la preferenza è stata data ai forti colpi perforanti da dietro uno scudo, che davano un'ottima protezione). Inoltre, i gladi avevano altri due indubbi vantaggi: erano tutti dello stesso tipo (in termini moderni - "seriale"), quindi un legionario che perdeva la sua arma in battaglia poteva usare l'arma di un compagno sconfitto senza alcun inconveniente. Inoltre, di solito le spade dell'antica Roma erano realizzate con ferro di qualità piuttosto bassa, quindi erano economiche da produrre, il che significa che tali armi potevano essere prodotte in quantità molto grandi, il che a sua volta portò ad un aumento dell'esercito regolare.
Un fatto molto interessante è che, secondo gli storici, il gladius non è originariamente un'invenzione romana e molto probabilmente è stato preso in prestito dalle tribù che un tempo conquistarono la penisola iberica. Intorno al 3° secolo a.C., gli antichi romani presero in prestito una spada corta e diritta chiamata Gladius Hispaniensis (cioè “spada spagnola”) dalle tribù barbare (presumibilmente Galli o Celti). La stessa parola gladius potrebbe derivare dal celtico “kladyos” (“spada”), anche se alcuni esperti ritengono che questo termine possa derivare anche dal latino “clades” (“danno, ferita”) o “gladii” (“gambo” ) ). Ma, in un modo o nell'altro, furono i romani a “immortalare” questa spada corta.
Gladius è una spada a doppio taglio con punta a forma di cuneo, utilizzata per perforare e sferrare colpi al nemico. L'elsa resistente aveva un manico convesso che poteva avere rientranze per le dita. La resistenza della spada era assicurata dalla forgiatura in lotti, unendo insieme diverse strisce di acciaio mediante colpi, oppure dalla sezione trasversale a forma di diamante della lama quando fabbricata da un unico pezzo di acciaio ad alto tenore di carbonio. Quando veniva prodotta mediante forgiatura in lotti, al centro della spada era situato un canale rivolto verso il basso.
Molto spesso sulle spade veniva indicato il nome del proprietario, che veniva impresso sulla lama o inciso.
I colpi lancinanti avevano un grande effetto durante le battaglie perché le ferite da puntura, specialmente nella cavità addominale, di regola, erano sempre fatali. Ma in alcune situazioni, i colpi taglienti e taglienti venivano applicati con un gladio, come evidenziato da Tito Livio nei suoi resoconti sulle guerre macedoni, che parla dei soldati macedoni spaventati quando videro i corpi tagliati dei soldati.
Nonostante la strategia principale dei fanti - sferrare colpi lancinanti allo stomaco, durante l'addestramento miravano a ottenere qualsiasi vantaggio in battaglia, non esclusa la possibilità di colpire il nemico sotto il livello degli scudi, danneggiando le rotule con colpi taglienti.
Esistono quattro tipi di gladio.
Gladio spagnolo
Utilizzato entro e non oltre il 200 a.C. al 20 a.C La lunghezza della lama è di circa 60-68 cm. La lunghezza della spada è di circa 75-85 cm. La larghezza della spada è di circa 5 cm. Era il più grande e pesante dei gladi. Il più antico e il più lungo dei gladi, aveva una forma pronunciata a forma di foglia. Il peso massimo era di circa 1 kg, quello standard pesava circa 900 g con manico in legno.
Gladio "Magonza"
Magonza fu fondata come accampamento permanente romano a Moguntiacum intorno al 13 a.C. Questo grande campo forniva la base demografica per la città in crescita attorno ad esso. La fabbricazione delle spade probabilmente iniziò nell'accampamento e continuò in città; ad esempio, Gaius Gentlius Victor, un veterano della Legio XXII, utilizzò il suo bonus di smobilitazione per avviare un'attività come gladiario, produttore e commerciante di armi. Le spade prodotte a Magonza venivano vendute principalmente al nord. La variante di Magonza del gladio era caratterizzata da una piccola lama e una lunga punta. Lunghezza lama 50-55 cm. Lunghezza spada 65-70 cm. Larghezza lama circa 7 cm. Peso spada circa 800 g. (con manico in legno). Il gladio del tipo Magonza era destinato principalmente a pugnalare. Per quanto riguarda il tritare, se applicato in modo maldestro, potrebbe addirittura danneggiare la lama.
Gladio Fulham
La spada che ha dato il nome al tipo è stata rinvenuta nel Tamigi vicino a Fulham e deve quindi risalire a dopo l'occupazione romana della Gran Bretagna. Ciò avvenne dopo l'invasione di Aulia Platius nel 43 d.C. Fu utilizzato fino alla fine di quello stesso secolo. È considerato un collegamento intermedio tra il tipo Magonza e il tipo Pompei. Alcuni lo considerano uno sviluppo del tipo Magonza, o semplicemente di questo tipo. La lama è leggermente più stretta del tipo Mainz, la differenza principale è la punta triangolare. Lunghezza lama 50-55 cm. Lunghezza spada 65-70 cm. La larghezza della lama è di circa 6 cm. Il peso della spada è di circa 700 g. (con manico in legno).
Gladio "Pompei"
Prende il nome in tempi moderni da Pompei, una città romana in cui morirono molti dei suoi abitanti - nonostante gli sforzi della marina romana per evacuare le persone - che fu distrutta da un'eruzione vulcanica nel 79 d.C. Lì sono stati trovati quattro esempi di spade. La spada ha lame parallele e punta triangolare. È il più corto dei gladi. Vale la pena notare che viene spesso confuso con la spatha, che era un'arma da taglio più lunga utilizzata dagli ausiliari a cavallo. A differenza del suo predecessore, era molto più adatto per tagliare il nemico, mentre la sua capacità di penetrazione durante un colpo pugnalato diminuiva. Nel corso degli anni il tipo Pompei si è allungato e le versioni successive vengono denominate semi-spatas. Lunghezza lama 45-50 cm. Lunghezza della spada 60-65 cm. La larghezza della lama è di circa 5 cm. Il peso della spada è di circa 700 g. (con manico in legno).
Nel terzo secolo, anche il gladio di tipo pompeiano non era più abbastanza efficace.
La tattica delle legioni divenne più difensiva che offensiva, come nei secoli precedenti. C'era un urgente bisogno di spade più lunghe, adatte al combattimento singolo o al combattimento in una formazione relativamente libera. E poi la fanteria romana si armò della spada da cavalleria, detta “spata”.
Una lunga spada inventata dai Celti, ma ampiamente utilizzata dalla cavalleria romana. Inizialmente, la spatha fu creata e usata dai Celti come spada per fanti, che aveva il bordo arrotondato ed era destinata a sferrare colpi taglienti, ma col tempo, avendo apprezzato il bordo del gladio, destinato ai colpi lancinanti, i Celti affilarono la spatha, e i guerrieri a cavallo romani ammirarono con questa lunga spada, la presero in servizio. A causa del centro di gravità spostato più vicino alla punta, questa spada era ideale per i combattimenti a cavallo.
La spatha romana raggiungeva un peso di 2 kg, la larghezza della lama variava dai 4 ai 5 centimetri, e la lunghezza dai 60 agli 80 centimetri circa. Il manico della spatha romana era realizzato allo stesso modo del gladius, in legno e osso.
Quando la spada apparve nell'Impero Romano, gli ufficiali di cavalleria iniziarono prima ad armarsi con essa, poi l'intera cavalleria cambiò le armi, seguita da unità ausiliarie che non avevano una formazione e parteciparono alla battaglia più in forma sparsa, cioè , la battaglia con loro era divisa in combattimenti. Ben presto gli ufficiali delle unità di fanteria apprezzarono questa spada e col tempo non solo se ne armarono, ma armarono anche i legionari ordinari. Certo, alcuni legionari rimasero fedeli al gladio, ma ben presto esso passò completamente alla storia, lasciando il posto alla più pratica spatha.
Pugio
Pugnale usato dai soldati romani come arma da fianco. Si ritiene che il pugio fosse inteso come arma ausiliaria, ma il suo esatto utilizzo in combattimento rimane poco chiaro. I tentativi di identificare il pugio come un coltello multiuso sono fuorvianti perché la forma della lama non è adatta a questo scopo. In ogni caso, sulle installazioni militari romane c'erano molti coltelli di varie forme e dimensioni, e quindi non c'era bisogno di utilizzare solo il pugio per scopi universali. I funzionari dell'Impero Romano indossavano pugnali decorati mentre erano in servizio sul posto di lavoro. Alcuni portavano segretamente i pugnali, per proteggersi da circostanze impreviste. In generale, questo pugnale serviva come arma di omicidio e suicidio; ad esempio, i cospiratori che infersero un colpo mortale a Giulio Cesare usarono il pugio per questo.
In definitiva il pugio derivava da originali spagnoli di vario tipo. Tuttavia, all'inizio del I secolo d.C., le repliche di questo pugnale romano avevano tipicamente una lama larga, che poteva essere a forma di foglia. Potrebbe anche esserci una forma alternativa della lama con la punta che si restringe verso la punta delle lame larghe da circa la metà della lunghezza della lama. Le lame variano nel formato da 18 cm a 28 cm di lunghezza e 5 cm o più di larghezza. La nervatura centrale si estendeva per l'intera lunghezza di ciascun lato della lama, posizionandosi al centro o formando un'estensione in entrambe le direzioni. Il codolo era largo e piatto, i rivestimenti del manico erano rivettati su di esso, così come sulle spalle della lama. Il pomo era originariamente di forma rotonda, ma all'inizio del I secolo d.C. aveva acquisito una forma trapezoidale, spesso sormontata da tre rivetti decorativi.
Il pugio aveva il proprio fodero. Durante il secondo quarto del I secolo d.C. furono utilizzati tre tipi di fodero. Tutti avevano quattro anelli per il fissaggio e un'estensione convessa alla quale era attaccato un grosso rivetto. A giudicare dagli esempi di usura giunti fino a noi, i due anelli inferiori non venivano utilizzati per fissare il fodero. Il primo tipo era costituito da piastre metalliche curve (solitamente ferro). Queste piastre erano posizionate sui lati anteriore e posteriore del fodero e sembravano sigillare il "rivestimento" di legno. La parte anteriore era solitamente riccamente decorata con intarsi in ottone o argento, nonché smalto rosso, giallo o verde. Una caratteristica di questi foderi era la libera circolazione dei pendenti ad anello fissati tramite elementi di fissaggio a forcella rivettati. Non sono mai stati trovati ricostruzioni moderne di questi foderi, costituiti da lastre di rame fissate con rivetti; Questo errore comune si verifica a causa dell'errata interpretazione del disegno a tratteggio nel rapporto archeologico del fodero in ferro di tipo "A", che era semplicemente decorato con intarsi in argento e rivetti decorativi.
Il secondo tipo di fodero era di legno e, presumibilmente, rivestito di pelle. Sulla parte anteriore di tali guaine erano fissate delle placche metalliche (quasi sempre di ferro). Questo piatto era piuttosto liscio e riccamente decorato con intarsi in argento (a volte stagno) e smalto. Gli anelli pendenti somigliavano a piccole fibbie militari romane ed erano incernierati ai lati della cassa. Il terzo tipo (il "tipo a telaio") era di ferro e consisteva in una coppia di guide curve che correvano insieme e svasate all'estremità inferiore del fodero per formare un'estremità sferica. I corridori erano collegati da due strisce orizzontali nella parte superiore e centrale del fodero.
Gasta
Il tipo principale di lancia di fanteria nell'antica Roma, sebbene in diversi periodi di tempo il nome ghast denotasse diversi tipi di lance, ad esempio, il poeta romano Ennio, intorno al 3 ° secolo a.C., menziona ghast nelle sue opere come designazione per un lancio lancia, che in realtà significava tempo è il significato generalmente accettato. Secondo il moderno giudizio degli storici, inizialmente era consuetudine armare i legionari con lance pesanti, che ora vengono comunemente chiamate ghast. In un secondo momento, le lance pesanti furono sostituite con dardi più leggeri: i pilum. I Ghast sono divisi in tre tipi, ognuno dei quali può essere tranquillamente definito un tipo separato di lancia:
1. Una lancia da fanteria pesante destinata esclusivamente al combattimento ravvicinato.
2. Una lancia accorciata, utilizzata sia come arma da mischia che come arma da lancio.
3. Un dardo leggero destinato esclusivamente al lancio.
Fino al III secolo a.C., il ghasta era in servizio con i soldati di fanteria pesante che marciavano in prima linea. Questi soldati furono chiamati così, in onore della lancia con cui entrarono in battaglia: hastati, anche se in seguito la lancia scomparve dall'uso generale, i guerrieri continuarono a essere chiamati hastati. Nonostante l'hastu fosse sostituito dal pilum per i soldati comuni, la lancia pesante rimase in servizio presso i principi e i triarii, ma durò anche fino all'inizio del I secolo a.C. C'era la fanteria leggera (velites), che non aveva un ordine di formazione, che era sempre armata con ghast da lancio leggero (hasta velitaris).
La lunghezza del ghast era di circa 2 m, di cui la parte del leone la faceva il fusto (un rapporto completamente diverso rispetto al pilum), che era lungo circa 170 cm ed era costituito principalmente da cenere. La punta era inizialmente forgiata in bronzo, ma in seguito il bronzo fu sostituito dal ferro (come in molti altri casi associati alle armi dell'antico esercito romano), la lunghezza della punta era in media di 30 cm. Gradi dei soldati anziani: beneficiari, frumentari, speculatori. che spesso svolgevano incarichi speciali, avevano lance di forma speciale, sottolineando il loro status. Le punte delle loro lance erano decorate con anelli di ferro. È noto che i romani avevano un premio militare speciale: una lancia d'oro o d'argento (hasta pura). Nell'era dell'Impero, veniva solitamente assegnato agli ufficiali delle legioni, a cominciare dai centurioni anziani.
Pilum
Un'arma a lama in asta dei legionari romani, un tipo di dardo progettato per essere lanciato da una breve distanza contro un nemico. La sua esatta origine non è stata ancora chiarita. Forse fu inventato dai Latini, o forse preso in prestito dai Sanniti o dagli Etruschi. Il pilum si diffuse nell'esercito repubblicano di Roma e fu in servizio presso i legionari fino all'inizio del IV secolo d.C. e. È utilizzato principalmente dai fanti e durante il periodo dell'esercito repubblicano (fine VI secolo a.C. - 27 a.C.) era utilizzato da un certo tipo di esercito: veliti armati leggermente e hastati di fanteria pesante. Intorno al 100 a.C. Il generale Marius introduce il pilum come parte dell'equipaggiamento di ogni legionario.
Inizialmente è costituito da una lunga punta di ferro, di lunghezza pari all'asta. L'albero veniva inserito a metà nella punta e la lunghezza totale era di circa 1,5–2 metri. La parte metallica era sottile, fino a 1 cm di diametro, lunga 0,6-1 m e con punta seghettata o piramidale. Durante il regno di Cesare esistevano varie versioni del tipo originale: la punta veniva allungata o accorciata. I pilum erano anche divisi in leggeri (fino a 2 kg) e pesanti (fino a 5 kg). La sua principale differenza rispetto alla lancia era la lunga parte in ferro. Ciò serviva a garantire che, se lo scudo del nemico fosse stato colpito, non potesse essere tagliato con una spada.
La punta del pilum poteva essere fissata utilizzando un tubo all'estremità o una linguetta piatta, fissata all'asta con 1-2 rivetti. Molti dardi con una "lingua" lungo i bordi della parte piatta dei bordi erano piegati e ricoprivano l'asta in modo che la punta vi si adattasse meglio. Un pilum ben conservato (circa 80 aC) con una seconda variante di fissaggio la punta è stata trovata a Valencia (Spagna) e a Oberraden (Germania settentrionale). Grazie a questi ritrovamenti si conferma che entro la metà del I secolo a.C. il pilum diventa più leggero. Copie precedenti furono scoperte nell'Etruria settentrionale, vicino a Telamone. Le punte di questi campioni erano molto corte, lunghe solo 25-30 cm. C'erano anche pilum con una parte piatta lunga 57-75 cm. Durante le famose riforme militari del capo militare Gaio Mario, notò che la lancia non sempre si piegava quando veniva colpita, e il nemico poteva raccoglierla e usarla. Per evitare ciò, uno dei rivetti viene sostituito con un perno di legno, che si rompe all'impatto, e i lati della linguetta non vengono piegati.
I pilum pesanti hanno un'asta che si rastrema verso l'estremità; all'incrocio con la punta è presente un pesante contrappeso rotondo, che dovrebbe aumentare la forza d'urto della lancia. Questo tipo di pilum è raffigurato nel rilievo della Cancilleria a Roma, che mostra i pretoriani armati con essi.
Fondamentalmente, la lancia era destinata a essere lanciata contro il nemico, poiché veniva usata molto meno spesso come arma perforante. Lo hanno lanciato prima dell'inizio del combattimento corpo a corpo a una distanza compresa tra 7 e 25 metri, campioni più leggeri - fino a 65 metri. Anche se il pilum rimaneva semplicemente bloccato nello scudo del nemico senza causare danni significativi, rendeva difficile al nemico muoversi nel combattimento ravvicinato. In questo caso, l'asta morbida della punta spesso si piegava, rendendo impossibile estrarla o tagliarla rapidamente. Usare lo scudo dopo questo divenne scomodo e dovette essere scartato. Se lo scudo rimaneva nelle mani del nemico, il legionario arrivato in tempo saliva sull'asta del pilum bloccato e abbassava lo scudo del nemico, formando un comodo spazio per colpire con una lancia o una spada. I pilum pesanti potrebbero, con la forza del colpo, penetrare non solo nello scudo, ma anche nel nemico in armatura. Ciò è stato dimostrato da test moderni. Da una distanza di 5 metri, il pilum romano perfora una tavola di pino di tre centimetri e uno strato di compensato di due centimetri.
Successivamente il pilum lascia il posto ad uno spiculum più leggero. Ma esiste la possibilità che si tratti di nomi diversi per lo stesso tipo di arma. Con il declino e il crollo dell'Impero Romano, la fanteria regolare - i legionari - diventa un ricordo del passato e, insieme a loro, i pilum scompaiono dal campo di battaglia. Inizia l'era del dominio sul campo di battaglia della cavalleria pesante e della lunga lancia.
Lancia
Lancia della cavalleria romana.
Giuseppe Flavio menziona che la cavalleria romana sconfisse quella ebraica grazie alle lunghe lance. Successivamente, dopo la crisi del III secolo, nella fanteria furono introdotti nuovi modelli di lance, in sostituzione dei pilum. Nuovi tipi di lance da lancio (apparsi dopo le riforme di Diocleziano), secondo Vegezio, sono vertullum, spicullum e plumbata. I primi due erano dardi metri, e la plumbata era un dardo piumato di 60 cm appesantito in piombo.
I pretoriani furono integrati da distaccamenti di lanciarii: unità simili apparvero nelle legioni per proteggere persone particolarmente importanti; La lancea era un'arma di servizio, ma la lancia non veniva utilizzata all'interno, e i lanciarii non erano limitati nella scelta di armi aggiuntive durante il crollo dell'impero, tale guardia era un attributo di qualsiasi comandante importante o, meno spesso,; un senatore.
Plumbata.
La prima menzione dell'uso in combattimento dei plumbat risale all'antica Grecia, in cui i guerrieri usavano i plumbat a partire dal 500 a.C. circa, ma l'uso più famoso dei plumbat negli eserciti tardo romani e bizantini.
Nella descrizione, Vegetia plumbata è un'arma da lancio a lungo raggio. I guerrieri pesantemente armati che prestavano servizio nella legione romana, oltre all'equipaggiamento tradizionale, erano equipaggiati con cinque piombati, che indossavano all'interno dello scudo. I soldati usavano i plumbat come arma offensiva durante il primo assalto e come arma difensiva durante un attacco nemico. L'esercizio costante ha permesso loro di acquisire una tale esperienza nel maneggiare le armi che i nemici e i loro cavalli sono rimasti sbalorditi prima che si arrivasse al combattimento corpo a corpo, e anche prima che arrivassero a portata di un dardo o di una freccia. Pertanto, allo stesso tempo, i guerrieri sul campo di battaglia combinavano le qualità della fanteria pesante e dei fucilieri. Gli schermagliatori, che combattevano davanti alla formazione all'inizio della battaglia, avevano in servizio anche degli plumbat. Tornando indietro con l'inizio del combattimento corpo a corpo sotto la propria copertura, continuarono a sparare contro il nemico. Allo stesso tempo, i piombati li lanciarono lungo una traiettoria alta, sopra le teste di chi precedeva. Vegetius prevede espressamente la necessità di armare con plumbat i triarii che si trovavano nelle ultime file dello schieramento. Consigliava anche ai suoi lettori di usare i plumbat nella guerra d'assedio, sia quando si proteggevano le mura dagli attacchi nemici che quando si assaltavano le fortificazioni nemiche.
La comparsa della plumbata avviene a seguito dello sviluppo della stessa tendenza ad aumentare la massa dell'arma per potenziare l'energia del suo lancio. Se però il pilum, dotato di piombino di piombo, poteva essere lanciato solo a 20 m, e a questa distanza trapassava lo scudo e il portatore che si nascondeva dietro di esso, allora quello più leggero per la riduzione delle dimensioni del l'asta e la massiccia parte in ferro della punta del plumbat volavano a 50-60 m, che è paragonabile alla portata di lancio di un dardo leggero. Il plumbatu si distingue da quest'ultimo per le sue dimensioni più piccole e per una speciale tecnica di lancio, in cui il guerriero prendeva l'asta con le dita per la coda e la lanciava con un movimento della spalla del braccio, come lanciare una mazza o una mazza da lancio. In questo caso, l'asta del piombino diventava un'estensione della mano del lanciatore e aumentava la leva di lancio, mentre il piombo impartiva ulteriore energia cinetica al proiettile. Pertanto, con una dimensione inferiore a quella di un dardo, la plumbata riceveva una maggiore riserva iniziale di energia, che consentiva di lanciarla ad una distanza almeno non inferiore alla distanza di lancio di un dardo. Inoltre, se il dardo alla fine sprecava quasi completamente l'energia di lancio iniziale impartitagli e, anche quando colpiva il bersaglio, non poteva causargli alcun danno evidente, allora la plumbata, anche alla massima distanza del suo volo, manteneva un fornitura di energia sufficiente a colpire la vittima.
Un vantaggio importante degli avversari dei romani era il possesso di armi a lungo raggio, che potevano essere utilizzate per sparare a legioni strettamente formate da distanze estreme. L'effetto distruttivo di tali bombardamenti fu probabilmente del tutto insignificante e la sua efficacia fu ottenuta indebolendo la resistenza del nemico e la sua fiducia nelle proprie forze. Una risposta adeguata da parte dei romani fu l'uso di proiettili che avevano una distanza di fuoco e un potere distruttivo maggiori rispetto al nemico. Come notato in precedenza, la plumbata veniva lanciata a una distanza pari alla portata del dardo. Ma se il dardo alla massima distanza si rivelava completamente impotente, allora la plumbata, anche alla fine, conservava abbastanza energia per colpire la sua vittima e renderla incapace. In particolare, Vegezio sottolinea questa proprietà della plumbata quando dice che i romani “ferivano i nemici e i loro cavalli prima che si arrivasse al combattimento corpo a corpo, e anche prima che arrivassero nel raggio di un dardo o di una freccia”.
L'asta corta del plumbat e la tecnica di lancio, che non richiedeva molto spazio, permettevano alle retrovie della formazione di sparare al nemico anche durante il combattimento corpo a corpo. Per non colpire chi stava davanti, i proiettili venivano lanciati verso l'alto con un ampio angolo. A causa dell'elevato angolo di incidenza del plumbat, ha perforato il bersaglio dall'alto verso il basso, con un angolo compreso tra 30 e 70 gradi, il che ha permesso di colpire la testa, il collo e le spalle di un guerriero nascosto dietro uno scudo. In un momento in cui tutta l’attenzione dei combattenti era rivolta al nemico, i proiettili che piovevano dall’alto erano particolarmente pericolosi perché “non potevano essere né visti né evitati”.
Durante la campagna africana del 530, una plumbata lanciata dal lanciere di Belisario Giovanni d'Armenia trafisse l'elmo del nipote del re vandalo Geiserico e gli inflisse una ferita mortale, dalla quale morì presto, ma l'elmo era fatto del più spesso metallo.